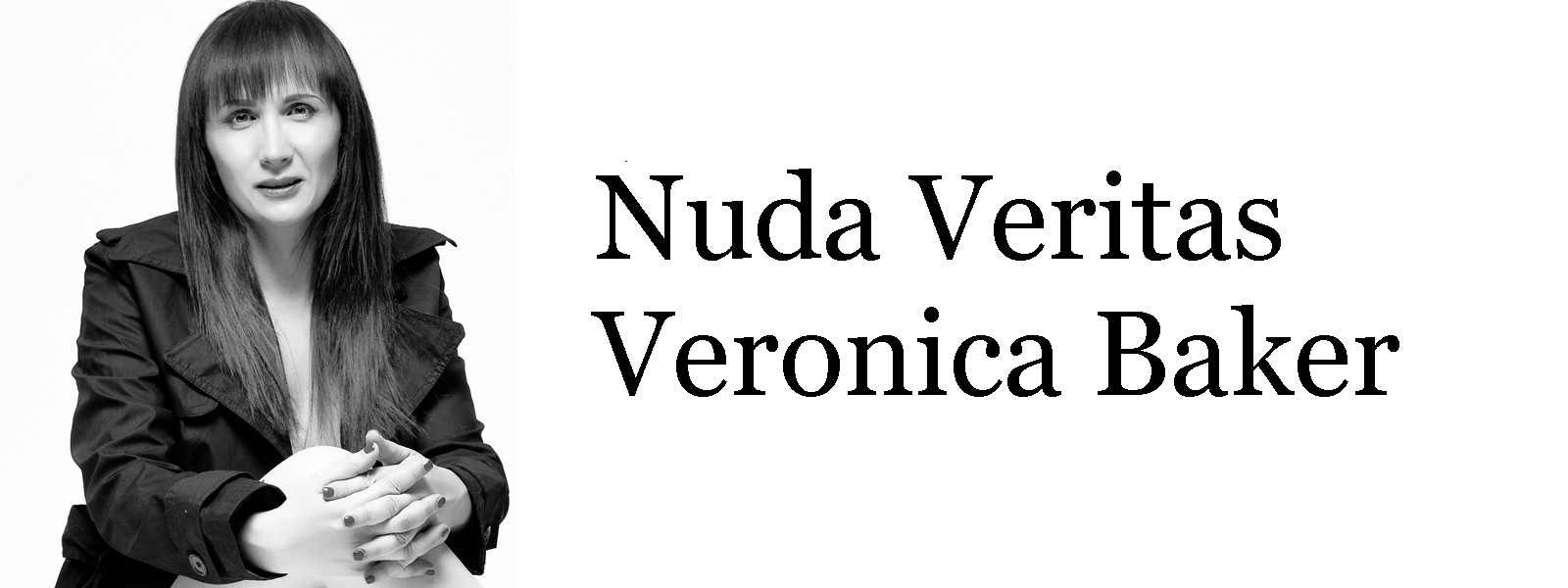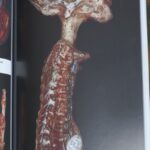Gennaio 10, 2025 Storia nascosta
Il cittadino italiano, infatti, come ogni altro straniero non possedeva diritti acquisiti.
Immigrazione italiana nel mondo

Attualmente, con la consueta tempestività della memoria collettiva nel rimuovere un peso divenuto ormai molto ingombrante, si tende a considerare l’immigrazione dei nostri connazionali come un evento assai remoto nella storia.
La percezione di essere sempre stati un Paese di “accoglienza” ha ormai preso il sopravvento, con quanto ne deriva in termini economici, giuridici e sociali.
In questo paragone, in questo momento, la grande assente sembra proprio essere la Memoria.
Infatti, il bilancio negativo tra uscite e rimpatri viene superato solo negli anni ’80 e, sebbene già a partire dagli anni ’70 l’inversione di tendenza fosse evidente, il fenomeno dell’emigrazione all’estero coinvolgeva comunque centinaia di migliaia di persone.
In primo luogo, è necessario chiarire la rilevanza del flusso migratorio degli italiani : si è trattato, senza paura di essere smentiti, del più imponente flusso migratorio della storia moderna e contemporanea.
A partire dalla prima metà dell’Ottocento, quasi venticinque milioni di italiani hanno cercato “fortuna” in ogni angolo del mondo.
Se si considera la popolazione italiana subito dopo la Breccia di Porta Pia (1870), è possibile stimare facilmente le dimensioni del fenomeno.
Inoltre, un altro elemento di fondamentale importanza è la prevalenza “settentrionale” del flusso di popolazione in uscita sin dai primi del Novecento, come dimostrato dalla quantità e qualità delle informazioni disponibili online per le regioni del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia, e più in generale per tutte le regioni dell’Italia settentrionale.
Un’ulteriore conferma proviene dalle stime sul numero di italiani nel mondo, attualmente calcolato in circa 60 milioni di persone, sebbene solo quattro milioni siano quelli censiti dall’AIRE (l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, amministrata dal Ministero dell’Interno).
Se istintivamente siamo ancora portati a pensare alle navi della speranza de “La leggenda del pianista sull’oceano“, che trasportavano a Ellis Island, la frontiera d’ingresso negli Stati Uniti, una moltitudine di persone disperate o quasi (chi scrive queste righe, ad esempio, conserva un inquietante ricordo del Museo dell’Immigrazione ivi ubicato, dall’altra parte del porto di New York City), nella realtà la storia riporta gli ultimissimi fuochi di questo fenomeno al 1970, esattamente durante i campionati mondiali di calcio in Messico.
Il quotidiano palermitano L’Ora pubblicò sconcertanti dichiarazioni sull’esistenza di “un’organizzazione malavitosa che si occupava di gestire gli espatri clandestini negli Stati Uniti, passando attraverso il confine messicano, di cittadini italiani che si erano trasferiti in quel paese nelle vesti di tifosi della Nazionale di calcio italiana“.
Il clamore della vicenda fu notevole, anche se, a mio parere, stona con un’emigrazione che aveva già vissuto episodi di estrema drammaticità negli anni precedenti (basta pensare alla morte degli immigrati clandestini italiani sui valichi del Nord-Ovest, mentre cercavano di raggiungere la Francia) e che ancora manteneva una massiccia consistenza nelle aree dell’Europa in cui abitualmente si svolgeva quel ruolo nell’industria e nella società, un ruolo che oggigiorno si attribuisce in modo del tutto identico alle popolazioni eurasiatiche, ai gruppi etnici mediterranei e africani.
Nel biennio 1971-1973, superato ormai definitivamente anche il periodo di massima immigrazione italiana in America e in Australia, il numero di cittadini italiani in Germania si aggirava costantemente intorno alle 50.000 unità.
Se nei primi anni Sessanta gli italiani rappresentavano praticamente la metà degli immigrati in Germania con 121.000 lavoratori, nel 1973 erano diventati ben 423.000, il numero più alto di sempre.
Occorre inoltre sottolineare che, ancora nel 1973, quasi i tre quarti dei lavoratori erano non qualificati.

In altre parole, non si trattava di studenti, tecnici specializzati o dirigenti, categorie che comunque erano presenti in Germania in maniera significativa.
Il numero di italiani in Germania passò dai 400.000 della fine degli anni Sessanta ai 650.000 del 1972, per poi assestarsi intorno ai 600.000 nel 1975.
La situazione non era molto diversa in Svizzera, dove la presenza dell’immigrato era subordinata a quanto previsto dalla Legge federale sul soggiorno e l’insediamento degli stranieri del 1931 e del 1948, in vigore fino al 1978. In questa legge, più volte è stato sancito il “principio della libera decisione delle autorità“, che di fatto subordinava le garanzie sostanziali del soggiorno in territorio svizzero alla soggettività del giudizio insindacabile delle autorità locali.
Il cittadino italiano, infatti, come ogni altro straniero, non possedeva diritti acquisiti e la popolazione italiana in particolare era soggetta a episodi di discriminazione razziale all’origine di non trascurabili tensioni diplomatiche tra i due Paesi.
All’inizio degli anni Sessanta, i nostri connazionali costituivano la maggioranza della forza lavoro straniera in Svizzera, di cui rappresentavano i due terzi del totale, e nel 1970 erano ancora oltre il 60 per cento, per poi calare, in coincidenza con la crisi economica del periodo considerato, a circa il 40 per cento nel 1975, anno in cui si inizierà a lasciare a jugoslavi e turchi il non invidiabile ruolo di ultimi della classe, ma in cui si raggiungerà anche la massima consistenza della popolazione straniera residente, con 587.000 persone.
I settori dell’edilizia, dell’abbigliamento e del tessile sono quelli che registrano la maggiore presenza, rispettivamente con l’86,3%, il 79,4% e il 76% nel 1968, per lo più con mansioni di basso livello.
La presenza è invece scarsa nei settori più qualificati (tecnico, commercio, servizi, sanità), a conferma del basso profilo culturale e professionale dei nostri emigranti di allora.