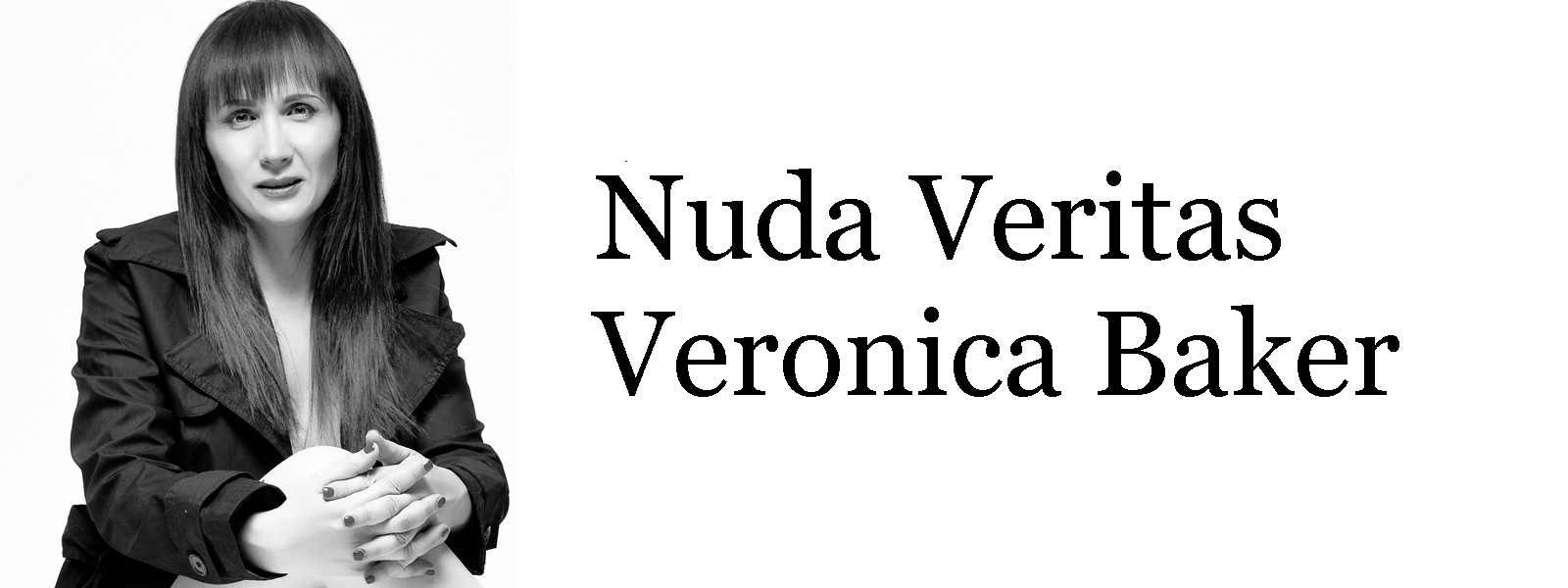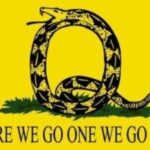Novembre 25, 2024 La Medicina dell’Anima
Non pensare che si possa diventare felici producendo l’infelicità altrui.
Pregiudizi e stereotipi. Non sarebbe meglio iniziare a vivere come esseri umani più evoluti ?
Introduzione
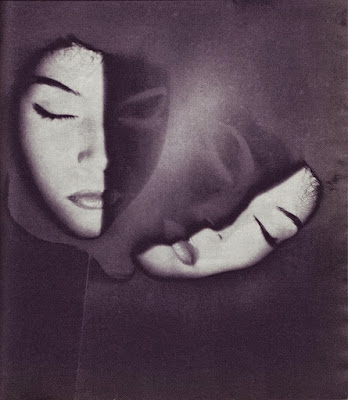
Tutte le società producono stranieri, ma ognuna ne produce un tipo particolare, secondo modalità uniche e irripetibili.
Se per “straniero” s’intende chi non si adatta alle mappe cognitive, morali o estetiche del mondo e, con la sua semplice presenza, rende opaco ciò che dovrebbe essere trasparente, allora gli stranieri sono persone in grado di sconvolgere i modelli di comportamento stabiliti e costituiscono un ostacolo alla realizzazione di una condizione di benessere generale.
Se compromettono la serenità diffondendo ansia e preoccupazione e fanno diventare seducenti esperienze strane e proibite ; se, in altri termini, oscurano e confondono le linee di demarcazione che devono rimanere ben visibili ; se, infine, provocano quello stato di incertezza che è fonte di inquietudine e smarrimento, allora tutte le società conosciute producono stranieri.
Il procedimento seguito per tracciare i confini e disegnare le mappe cognitive, estetiche e morali stabilisce, fin dall’inizio, gli individui destinati a rimanere ai margini o fuori dagli schemi di una esistenza ordinata e dotata di senso : gli stessi che, in seguito, saranno accusati di causare i disagi più fastidiosi e insopportabili.
L’incubo ossessivo che ha attraversato il nostro secolo, tristemente noto per i suoi orrori e terrori, strumenti di morte e tristi premonizioni, è stato compendiato nel modo migliore da George Orwell nella memorabile immagine dello stivale militare che calpesta un volto umano.
Nessun volto era al sicuro : chiunque poteva essere accusato di aver trasgredito o infranto regole e confini.
Poiché l’umanità fatica a sopportare i confini e i limiti e chi li oltrepassa diventa “straniero”, tutti avevano ragione di temere lo stivale che poteva schiacciare il volto estraneo nella polvere, calpestarlo fino a fargli perdere i connotati e dissuadere gli altri dall’attraversare illegalmente le frontiere.
Gli stivali militari fanno parte dell’uniforme.
Elias Canetti le ha definite una volta “uniformi assassine”.
A un certo punto del nostro secolo è diventato chiaro a tutti che gli uomini da temere maggiormente erano quelli in uniforme.
Le uniformi erano i simboli dei servitori dello stato inteso come fonte di tutti i poteri, soprattutto di quello coercitivo, sostenuto dall’autorità legittima di “auto-assolversi dall’accusa di crudeltà disumana”.
Indossando le uniformi, gli uomini “attivavano” ed incarnavano quel potere ; indossando gli stivali dell’uniforme, calpestavano ed umiliavano su ordine ed in nome dello stato.
Lo stato, che forniva ai propri uomini l’autorità e la preparazione per opprimere calpestando e allo stesso tempo garantiva la loro assoluzione, era percepito come fonte, custode e garante dell’ordine : la diga che protegge l’ordine dal caos.
Uno stato che aveva ben chiaro cosa dovesse essere l’ordine e che aveva la forza e l’arroganza di dichiarare ogni altro stato delle cose “disordine” e di costringere tutti a sottomettersi alle proprie condizioni.
Era, in altri termini, lo stato moderno che imponeva la legge dell’ordine nell’esistenza e definiva l’ordine come la chiarezza delle divisioni, delle classificazioni, delle ripartizioni e dei confini da rispettare severamente.
La figura tipica dello straniero “moderno” era il risultato dello zelo regolatore dello stato.
Gli stranieri non erano in grado di adeguarsi alla concezione dello stato moderno.
Quando si tracciano linee di divisione e si contrassegnano le zone così ottenute, tutto ciò che le altera o non le rispetta è fonte di insidia e rovina.
La riduzione o la sovradeterminazione semantica degli stranieri mette a repentaglio la visibilità delle suddivisioni e travolge i limiti che delimitano i confini.
Il semplice fatto che gli stranieri siano presenti, ai margini dei confini, ostacola e disturba l’adempimento dei compiti che lo Stato si prefigge di svolgere.
Lo straniero getta incertezza nel terreno in cui dovrebbe crescere la certezza e la trasparenza.
Nel progetto di realizzazione di una condizione di ordine armonioso e razionale, non c’è spazio – non potrebbe esserci spazio – per ciò che è “indefinito”, non ha una collocazione precisa ed è cognitivamente ambivalente.
L’impresa di costruzione dell’ordine è una guerra di logoramento dichiarata contro gli stranieri e tutto ciò che è anomalo.
Per combattere questa guerra, come affermava Lévi-Strauss, venivano impiegate ciclicamente due strategie alternative ma anche tra loro complementari.
La prima era “antropofagica” : consisteva nell’annullare gli stranieri “divorandoli” per poi metabolizzarli e trasformarli in una copia perfetta di sé.
Questa era la strategia dell’assimilazione.
Rendere simile il dissimile ;
Soffocare le distinzioni culturali o linguistiche ;
Proibire tutte le tradizioni e i legami, ad eccezione di quelli che favorivano il conformismo verso il nuovo e pervasivo ordine ;
Promuovere e rinforzare il solo ed unico criterio della conformità.
La seconda strategia era “antropoemica”: “espellere” gli stranieri, esiliarli dai limiti del mondo ordinato e impedire loro ogni comunicazione con chi sta dentro.
Questa era la strategia dell'”esclusione”.
Confinare gli stranieri all’interno delle mura ben visibili del ghetto o dietro gli invisibili e non meno tangibili divieti di “condivisione”, “connubium” e “commercium” ;
“Compiere un rituale di purificazione” attraverso l’espulsione degli stranieri oltre le frontiere del territorio amministrato ;
O, quando nessuna delle due misure era applicabile, distruggere fisicamente gli stranieri.
L’espressione più comune delle due strategie si manifestò nello scontro tra il progetto moderno di stampo liberale e quello nazionalista/razzista.
Secondo il progetto liberale, gli uomini erano diversi tra loro a causa delle tradizioni locali e particolaristiche in cui erano nati e cresciuti.
Ma in quanto “prodotti dell’educazione” e “creazioni” culturali, erano considerati flessibili e disponibili a essere forgiati.
Con la progressiva universalizzazione della condizione umana (che ha significato lo sradicamento di ogni particolarismo e delle forme di autorità che li legittimava, e di conseguenza la liberazione dello sviluppo umano dall’ormai inutile vincolo della nascita) questa diversità predeterminata, inevitabilmente imposta sulla possibilità di scelta degli individui, è destinata a scomparire.
Naturalmente, la prospettiva nazionalista/razzista si oppone radicalmente a questa visione, sostenendo che il cambiamento culturale proposto dal progetto liberale si scontra con limiti che nessuno sforzo umano è in grado di superare.
Alcuni individui non potranno mai essere convertiti in qualcosa di diverso da ciò che sono.
Non è possibile liberarli dai loro difetti, ma solo liberarsi “di loro”, comprese le loro peculiarità innate e le loro stranezze eterne.
Nella società moderna e sotto l’egida dello stato moderno, l’annullamento culturale e/o fisico degli stranieri e dell’anomalia era una “distruzione creativa”; un’opera di demolizione e, allo stesso tempo, di ricostruzione ; di profondo rimescolamento, ma anche di riordino.
Faceva parte integrante dello sforzo continuo di costruzione dell’ordine, della nazione e dello stato : era la loro condizione necessaria e parallela.
Inversamente, ogni volta che il progetto di costruzione dell’ordine lo prevedeva, certi abitanti del territorio da assoggettare al nuovo sistema diventavano stranieri da eliminare.
Sotto la pressione della spinta alla costruzione dell’ordine, gli stranieri vivevano, per così dire, in uno stato di estinzione sospesa.
Gli estranei erano, per definizione, un’anomalia da correggere.
La loro presenza era definita “a priori” come temporanea, proprio come uno stadio presente ma momentaneo nella storia dell’imminente ordine futuro.
La coesistenza permanente con l’estraneo e il diverso e la pragmatica del vivere con gli stranieri non doveva assolutamente essere considerata come una prospettiva reale.
Almeno finché la vita moderna avesse mantenuto le sue promesse, cioè finché avesse cercato di realizzare un ordine nuovo e globale e finché tale realizzazione fosse rimasta il compito di uno stato abbastanza ambizioso e intraprendente da perseguire l’obiettivo.
Tuttavia, queste condizioni non sembrano più verificarsi nell’epoca che Anthony Giddens chiama “tarda modernità”, Ulrich Beck “modernità riflessiva”, George Balandier “sur-modernità” e che io (insieme a molti altri) definisco “postmoderna”.
È l’epoca che stiamo vivendo ora, nella nostra parte di mondo (o meglio, vivere in un’epoca simile definisce ciò che consideriamo “la nostra parte di mondo”).
Fonte (rielaborata) : Zygmunt Bauman, La società dell’incertezza
Stereotipi

Nel 1933, due psicologi sociali chiesero a un centinaio di studenti dell’Università di Princeton di scegliere una lista di attributi collegandola ai vari gruppi etnici, e notarono che circa un quarto degli studenti identificava i vari gruppi etnici con 4-5 aggettivi caratteristici.
Gli psicologi notarono che quei giudizi non erano basati su esperienze o riscontri oggettivi, perché molti degli studenti non avevano mai incontrato un turco, per esempio, eppure attribuivano ai turchi delle caratteristiche che li classificavano in categorie sommarie : queste valutazioni superficiali si definiscono con il termine di “stereotipi”.
Il termine “stereotipo” nasce nelle officine tipografiche verso la fine del XVIII secolo e deriva dal greco stereos (solido) e typos (carattere).
Lo stereotipo era il calco che permetteva di riprodurre identiche figure e immagini nei volumi a stampa.
Il primo uso del termine in un campo diverso fu in ambito psichiatrico, per indicare dei comportamenti patologici caratterizzati da ripetizioni ossessive di gesti ed espressioni.
L’uso in campo sociale avvenne nel 1922, quando il giornalista politico Walter Lippman lo usò per indicare le categorie semplificate e sommarie che vengono usate per collocare “l’altro” e “il gruppo di cui l’altro fa parte”.
Infatti, il nostro rapporto con la realtà esterna non è diretto, ma mediato da immagini mentali, perché la mente umana non riesce a elaborare tutte le infinite sfumature con cui il mondo si presenta.
Secondo alcuni studiosi, le categorie mentali sono degli stereotipi che i membri di una cultura o sottocultura assumono, in quanto sono una caratteristica tipica della loro cultura.
Ogni volta che giudichiamo gli altri in base a uno stereotipo, gli attribuiamo un concetto che caratterizza tutto il suo gruppo, perciò usiamo un insieme rigido di credenze negative che il nostro gruppo condivide e che riguardano un gruppo esterno.
In fondo, gli stereotipi sono i meccanismi che fondano i pregiudizi e che permettono loro di sopravvivere.
Infatti, il pregiudizio si basa sulla convinzione che un certo gruppo abbia delle caratteristiche che lo contraddistinguono in modo specifico.
In base a questo ragionamento, si crede che lo stereotipo sia il nucleo cognitivo del pregiudizio, ovvero il nucleo delle credenze che riguardano una certa categoria di oggetti, credenze che vengono sempre rielaborate in modo coerente e che tendono a sostenere e riprodurre i pregiudizi che lo riguardano.
Ma come funziona uno stereotipo ?
L’orientamento più recente afferma che lo stereotipo coinvolge tre processi cognitivi.
Il primo processo che entra in gioco è la differenziazione o polarizzazione, per cui il gruppo esterno viene percepito come più omogeneo di quanto sia.
Questo processo, però, presenta dei rischi : porta, infatti, a sottovalutare le differenze tra le persone e, di conseguenza, a non riuscire a percepire le differenze tra gli individui che fanno parte del gruppo estraneo.
Il secondo processo mentale coinvolto è la memoria, perché si è notato che si tende a conservare più facilmente la traccia mnemonica dei fatti negativi riguardanti il gruppo rivale o estraneo, piuttosto che ricordare gli elementi favorevoli o positivi che lo riguardano.
Infine, vi è l’ultimo processo in base al quale tendiamo a ignorare le informazioni che contraddicono le nostre convinzioni, in quanto le invalidano.
Per questo motivo, preferiamo stabilire correlazioni tra caratteristiche non significative piuttosto che sentirci dare torto, costruendo così convinzioni illusorie.
E tutto questo accade a prescindere dal fatto che gli stereotipi sociali siano positivi o negativi.
Il tratto principale dello stereotipo è che esso viene accettato e condiviso dagli individui per ottenere una comprensione più efficace della realtà.
Tuttavia, lo stereotipo comporta l’accettazione di una rigidità mentale ancorata alla cultura e alla personalità dei membri di quella cultura.
È importante comprendere se tale rigidità sia immodificabile.
Un’indagine ha studiato gli stereotipi razziali esistenti nella società americana contemporanea.
La ricerca ha previsto un’indagine telefonica, contattando a caso dei numeri nel Connecticut, e ha intervistato 686 residenti.
Gli studi hanno messo in evidenza che gli stereotipi negativi sui “neri” erano molto più diffusi di quanto si credesse, perché la maggior parte degli intervistati aveva ancora delle credenze stereotipiche sui “neri”.
La maggioranza degli intervistati, infatti, affermò che i bianchi erano più abili nel pensiero astratto rispetto alle persone di colore e che le persone di colore avevano il cranio più sottile rispetto a quello dei bianchi.
Le statistiche di questi studi confermano che il modo migliore per prevenire la formazione di stereotipi è migliorare il livello di istruzione.
È emerso che chi non aveva un diploma di scuola superiore presentava una percentuale doppia di risposte contenenti stereotipi razziali rispetto a chi aveva il diploma di scuola superiore.
Gli studiosi confermano che vedere il mondo tramite idee rigide e interpretarlo per mezzo del filtro illusorio di questi rigidi schemi mentali è dovuto all’ignoranza.
Dunque, è necessario ammettere che nella nostra società esistono degli atteggiamenti che devono essere modificati, cosa difficile perché la nostra società si basa sugli stereotipi.
La società moderna sfrutta abilmente i meccanismi dell’inclusione e dell’esclusione sociale per alimentare il senso di dipendenza degli individui.
Il risultato è la creazione di interazioni sociali che alimentano l’inadeguatezza e l’incertezza delle persone.
Abbiamo creato contesti in cui l’esclusione mira a ridurre l’identità dei singoli, perciò escludiamo per ridurre le potenzialità, le capacità e le opportunità degli individui.
Lo stereotipo implica una dimensione totalizzante che non ammette la ricchezza della personalità di ciascun individuo.
Il diverso è l’altro, ossia il nero, lo straniero, il gay, la donna e la persona con disabilità fisica o mentale, che diventano gli elementi di disturbo per una società che esalta la perfezione, l’efficienza del corpo, la salute, la normalità e il consenso.
Tutto ciò che ricorda l’incapacità di accettare le regole diventa un limite e un disturbo.
La buona notizia per gli studiosi è che ogni stereotipo, anche il più diffuso e condiviso, non viene mai accettato da tutti, perciò possiamo agire sulla mancanza di consenso totale.
Errori e pregiudizi

Quando leggiamo che la nostra percezione del mondo dipende dalle concezioni che condividiamo con i nostri simili, pensiamo che stia parlando un filosofo indiano, ma questa affermazione è vera e viene confermata sperimentalmente dagli studiosi.
L’integrazione della dimensione psicologica e di quella sociale è un fatto vero : gli studi degli ultimi decenni confermano, infatti, che esiste una condivisione sociale di concezioni, atteggiamenti e valori che ci permette di ottenere una “stabilizzazione del quadro di vita degli individui e dei gruppi”, come afferma lo psicologo e sociologo rumeno Serge Moscovici.
Tuttavia, la stabilità che otteniamo comporta, come diretta conseguenza, una modifica dello “strumento di orientamento della percezione”.
Di conseguenza, ogni stimolo o sollecitazione esterna viene filtrato e ricostruito a livello sociale.
L’individuo possiede due dimensioni che si intrecciano e che devono essere conciliate : la dimensione individuale e quella collettiva.
È evidente, quindi, che le rappresentazioni sociali fanno parte della coscienza individuale.
Ciò non toglie che il singolo gode di una certa autonomia dai condizionamenti sociali : la coscienza individuale, infatti, può stabilire un ordine di preferenza dei valori e delle idee.
I soggetti costruiscono le rappresentazioni sociali per riuscire a dare un ordine a una realtà molto variegata e troppo complessa, e questo fenomeno viene rafforzato dal livello mentale.
Il processo di ancoraggio mentale consiste nel fatto che ogni fenomeno estraneo viene associato a una categoria nota che lo rende familiare e più accettabile.
Questo meccanismo mentale ci consente di assimilare tutto ciò che ci risulta troppo inconsueto o che rischia di causarci problemi.
La mente umana tende a creare una rete di categorie che le sono proprie e che le diventano familiari, e questo fatto ci consente di attivare confronti e paragoni tra l’elemento inconsueto e l’elemento che fa parte di una categoria già conosciuta.
Il processo dell’ancoraggio mentale spiega perché il cervello umano, per analizzare i dati insoliti o ignoti, ha la necessità di fare il confronto con l’ignoto.
Questo meccanismo è funzionale all’ottimizzazione del processo di classificazione e di reazione all’ambiente, ma dimostra anche la capacità di passare da elementi astratti a immagini concrete.
Ciò dimostra che un individuo può avere una convinzione e non esserne affatto consapevole.
Infatti, le persone non sempre agiscono in base a ciò che credono, ma spesso agiscono a favore di ciò che non condividono.
Alcune idee e atteggiamenti si radicano così profondamente da condizionare le nostre azioni senza che ce ne rendiamo conto.
Anche se non possiamo fornire delle prove oggettive a sostegno di molti pregiudizi, continuiamo a sostenere quelle convinzioni errate.
In questo frangente agisce un processo di adattamento sociale che implica la condivisione delle categorie sociali, ossia la condivisione di atti di valutazione e di interpretazione del mondo.
In questo modo, accettiamo anche l’organizzazione del mondo che ne consegue in termini di conoscenze e di regole di vita.
In parole povere, l’adattamento al mondo comporta anche l’accettazione di determinati schemi mentali, ossia di idee preconfezionate, ovvero di pregiudizi.
Nel 1954, Gordon W. Allport, psicologo e docente di Harvard, scrisse il saggio “La natura del pregiudizio”, che è passato alla storia delle scienze sociali come il punto di partenza per lo studio del complesso fenomeno.
Il termine “pregiudizio” deriva etimologicamente dal latino “praejudicium”, che indica un “giudizio emesso a priori”, ovvero la percezione di sentimenti positivi o negativi verso un oggetto senza avere avuto un’esperienza oggettiva o senza tener conto dell’esperienza avuta.
È importante capire che il pregiudizio, che sia positivo o negativo, equivale ad avvallare un giudizio senza avere sperimentato dei dati di fatto che possano suffragarlo, come nota ironicamente Allport.
Di solito, chi accetta un pregiudizio dirà di avere tutte le sue buone ragioni per pensare ciò che pensa.
In realtà, però, sappiamo che quel soggetto è vittima di un processo selettivo dei suoi ricordi.
Infatti, la rielaborazione dei ricordi si mescola alle dicerie ascoltate, poi quelle idee vengono ridotte a giudizi generalizzanti e vengono condivisi a livello sociale.
Secondo Allport, “il pregiudizio non può essere compreso se non a partire dai processi di pensiero normali, gli stessi che consentono all’individuo di padroneggiare la complessità degli stimoli ambientali e di agire efficacemente in rapporto ad essi“.
Il fatto che i pregiudizi si fondino su dati inconsistenti rende difficile sradicarli, perché non si può eliminare un fondamento inesistente.
Riflettendoci, vediamo che il pregiudizio si rivolge a un individuo che viene classificato sulla base della sua appartenenza a una categoria specifica, senza tener conto delle sue qualità particolari, e nei suoi confronti si reagisce in base a qualità che gli vengono attribuite perché attribuite al suo gruppo di appartenenza.
Tutto questo comporta che la dimensione di valutazione negativa è data in base all’appartenenza sociale, razziale, religiosa, politica, sessuale ed economica.
Ma se si stabilisce che esiste una disposizione naturale per cui esiste una certa scala sociale che differenzia la qualità degli individui, allora possiamo essere certi che il pregiudizio è diventato una discriminazione.
Se si ammettono espressioni o atteggiamenti di disprezzo e discriminazione verso un certo gruppo, si crea una linea di demarcazione che divide gli in-group, ovvero il gruppo privilegiato degli inclusi, e gli out-group, ossia il gruppo discriminato degli esclusi.
È certo che un pregiudizio non corrisponde mai a una realtà oggettiva, perché lo scopo delle discriminazioni è quello di creare una tendenza sociale nei confronti di gruppi specifici.
Tuttavia, è anche vero che alcune culture preferiscono determinate qualità e, per questo motivo, cercano di reprimere ciò che non amano.
È importante notare, inoltre, che per coltivare i pregiudizi è necessario avere sviluppato una buona competenza cognitiva.
Questo è dimostrato dal fatto che i bambini non possiedono alcun pregiudizio.
Paradossalmente, per essere così ottuso da avere pregiudizi si richiede il possesso di una competenza cognitiva.
Tutto questo è valido anche per l’affermazione di pregiudizi positivi verso il gruppo a cui si sente di appartenere, come evidente nelle sindromi da “popolo eletto” che hanno causato le orribili stragi del secolo scorso.
Il fatto di essere percepiti come categoria e non come individui è un fattore di spersonalizzazione che deve destare molta attenzione, perché lo stereotipo è il padre del pregiudizio.
Il pregiudizio può manifestarsi in vari modi, pertanto gli studiosi identificano varie categorie di pregiudizi.
Alcune discriminazioni sono ancora irrisolte e scottanti, come il pregiudizio nei confronti del femminile, del genere etnico-razziale, delle marginalità sociali, dei giovani e degli anziani, delle diversità di genere, delle disabilità fisiche e mentali, della tossicodipendenza.
Il pregiudizio etnico consiste in sentimenti di ostilità rivolti verso le minoranze etniche o i gruppi di etnia diversa.
Questo fenomeno vede entrare in gioco un complesso groviglio di fattori sociali, culturali e psicologici che entrano in conflitto, accentuando la difficoltà di risolvere la questione.
Negli ultimi decenni, si tende a ridurre le manifestazioni esplicite di intolleranza, ma l’ostilità è diventata latente e sopravvive sotto forma di atteggiamenti mascherati.
Si è passati dal vecchio modello di razzismo esplicito a quello implicito e occulto, molto più insidioso.
Ci sono vari modi per manifestare queste forme di razzismo occulto : molto spesso, per esempio, si preferisce contrastare le iniziative a favore delle minoranze.
Un altro modo è quello di legittimare le istanze razziste utilizzando in modo distorto gli stessi principi di uguaglianza e libertà individuale che dovrebbero tutelare gli individui (un esempio lampante è il WEF, che gode del patrocinio del noto nazista Klaus Schwab e dell’eugenista Yuval Noah Harari).

Questa è la strategia di chi sostiene che le iniziative a favore delle minoranze ledono i diritti delle maggioranze.
Spesso, queste idee distorte possono portare a manifestazioni di ostilità verso le minoranze.
Un’altra forma di razzismo strisciante è quella che comporta il rifiuto volontario di avere rapporti e contatti con le minoranze e il volontario scoraggiamento delle iniziative intraprese per riconoscere i loro diritti.
Per alimentare un clima ostile, non solo si mantiene una forte distanza dalle minoranze, ma si evidenziano anche i problemi che queste causano.
Questo è testimoniato anche dai detti stereotipati associati alle etnie o nazionalità, come quelli che affermano che “l’italiano è scansafatiche ed inaffidabile” o “lo svizzero è preciso e noioso”.
Questi vecchi stereotipi sono ancora permeati di pregiudizi che faticano a passare di moda.
Malgrado la scienza abbia dimostrato che affermare la superiorità di una razza su un’altra è un’idiozia senza basi scientifiche, vediamo che queste idiozie restano in auge.
L’errore di queste credenze errate è che vogliono confermare l’omogeneità di sensibilità, attitudini e orientamenti di un popolo che non si riscontra neppure in una famiglia.
Da scemenze di questo tipo sono nate le persecuzioni razziali nei confronti degli ebrei e di quei popoli che hanno pagato con il sangue il mantenimento della propria identità nazionale.
Se pensiamo ai pregiudizi di carattere sessuale, vediamo quelli contro le donne e, in generale, contro chi “disturba” le idee sull’identità maschio/femmina.
Per quanto riguarda le donne, va detto che da sempre vengono considerate il sesso debole e, non per caso, vengono loro attribuite qualità con valore socialmente negativo : debolezza, timore, emotività, irrazionalità, bisogno di tutela e protezione.
È vero anche che le vengono attribuite delle qualità auspicabili, ma sono pur sempre funzionali a un ruolo subalterno, come la dolcezza, la seduzione e la sensualità.
Lo sfondamento del soffitto di vetro sembra ancora molto lontano, forse perché quel vetro è stato temprato per essere anti-sfondamento.
Queste differenze vengono continuamente rimarcate, in un certo senso condividendo lo stesso destino infamante riservato alle altre minoranze sessuali.
Inoltre, l’efficientismo dei tempi moderni spinge ad avere un atteggiamento disturbato e discriminante anche nei confronti dei problemi legati alle abilità di chi è portatore di handicap fisici o mentali.
Ma l’infelicità della malattia mentale è più forte.
Questo è dovuto al fatto che si è maturata un’accettazione maggiore per la malattia fisica, che viene vista come socialmente più accettabile, mentre resta intatto il marchio infamante della malattia mentale.
Un valore condannabile viene riservato anche a tutti quelli che vengono giudicati in base ai pregiudizi sull’età, perché questo giudizio assurdo è giustificato dalle associazioni e dalle aspettative di comportamenti e sentimenti definiti in modo fisso e stereotipato.
I giovani non hanno altra scelta che rassegnarsi e accettare di essere associati allo stereotipo che essere giovani comporta essere persone meno responsabili e autonome nelle decisioni, quindi meno mature e consapevoli, e di conseguenza essere etichettati come “bamboccioni”.
Agli anziani, invece, tocca accettare di incarnare lo stereotipo della rigidità, della nostalgia del passato, del disinteresse per il futuro, dell’ostilità alle innovazioni, della collerica ostinazione e del piagnucolio.
La tragica comicità del paradosso è che l’unico modo per non diventare vecchi odiosi è morire giovani, seppure inetti.
Ma, dato che la soluzione mi sembra peggiore del male, non sarebbe meglio smetterla con queste idiozie e iniziare a vivere come esseri umani più evoluti ?